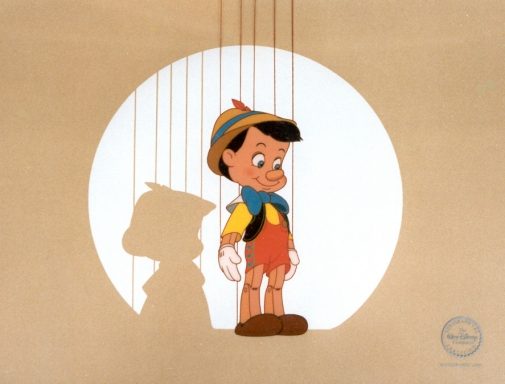Riassunto
della puntata precedente. In una tavola rotonda pubblicata su
"Liber" e intitolata Cosa conservare sugli scaffali
della biblioteca del Duemila? Classici che non hanno perso il loro
smalto e libri contemporanei che saranno letti per molto tempo
ancora, quattro moschettieri di comprovato valore negli studi
riguardanti la cosiddetta letteratura per l'infanzia hanno parlato
di libri importanti ma non hanno citato L'isola del tesoro. Il
titolare della presente rubrica, di molto risentito, ha sfidato i
quattro a fornire giustificazioni adeguate alla enormità del
caso, convocandoli per l'indomani dietro il convento delle
Carmelitane.
L'isola
del tesoro è un capolavoro assoluto
Quando
si parla a braccio, senza schemi prefissati (e senza poter
controllare quanto la coordinatrice della Tavola Rotonda ricava
dalla trascrizione del nastro inciso dal magnetofono) e trascinati
dagli interventi degli amici presenti, può accadere di
dimenticare di citare argomenti di decisivo rilievo. Così mi è
accaduto per Robert Louis Stevenson, che resta un caposaldo della
narrativa dell'Ottocento non soltanto per i libri scritti per
adulti ma soprattutto per L'isola del tesoro, che non può
essere considerato soltanto un libro per ragazzi ma in assoluto un
capolavoro, un romanzo fra quelli che hanno determinato la
struttura della narrativa di tutto un secolo.
Faccio
ammenda pubblica di que
sta
terribile trascuratezza, approfittandone per far notare che nella
tavola rotonda che "Liber" ha cortesemente ospitato si
possono criticare certe disfasie per i tempi dedicati ad argomenti
importanti e la scarsità di spazio lasciata ad argomenti
altrettanto importanti. Per esempio: si è parlato a lungo della
"Scala d'oro" e della "Biblioteca dei
miei ragazzi", mentre Kipling è stato ricordato di
sfuggita e Salgari non sufficientemente approfondito.
Ma
nessuno dei presenti - ne
sono
convinto - aveva intenzione di esaurire in una discussione orale
temi, testi e autori della letteratura per bambini e ragazzi.
Invece credo che sia tempo che qualche studioso affronti un
argomento fondamentale che riguarda il tema di cui ci occupiamo:
perché alle già scarse "Storie della letteratura per
l'infanzia" non si propone una "Storia sociale della
letteratura per l'infanzia"? Ritengo infatti che sia di
grande e urgente interesse approfondire come sia stato usato Cuore
quale esempio comportamentale rispetto ai suoi meriti letterari; o
perché nel Convegno del 1938, presieduto da Marinetti, si sia
volutamente dimenticato Salgari; o, anche, perché gli adulti di
oggi si siano tanto eccitati per la Gabbianella di Sepùlveda.
l'elenco è lungo e potrebbe continuare, ma mi auguro che questi
tre esempi risultino sufficientemente chiari.
P.S.
Va bene il duello (se non lo si fa per una ragione così valida,
quando mai sarebbe da farsi?) ma
è necessario specificare esattamente dietro quale Convento si
debba svolgere. Dumas era più preciso: le Carmelitane erano
quelle scalze. Adesso, dopo Bernanos, possono sorgere alcuni
dubbi.
ROBERTO
DENTI
L'isola
del tesoro, un libro da portare sull'isola deserta
Accolgo
il guanto della sfida, a patto che sia io a scegliere l'arma del
duello: un ombrello, per ripararmi dagli spruzzi d'acqua sollevati
dall'ira di Pontremoli per la mancata menzione dell'Isola del
tesoro tra i classici da portare nel Duemila. Eppure, ben si
sa, lo so anch'io, che secondo lo scrittore scozzese un libro
serve per spedire a letto un bambino con qualche seducente
immagine da infilare nei sogni. Proprio da questa
"seducente" pedagogia del leggere partirei per indicare
la strada della lettura come una "scala d'oro" che da
Piccoli brividi fino all'Isola del tesoro sale su su di
gradino in gradino, dai libri con i buchi alle filastrocche di
Rodari, dalle fiabe alle prime letture (prendo dalla mia
"piletta" di libri, raccoman
dandoli, i più recenti Pirati del "Battello a vapore": Abbaia,
George di Feiffer, Presto, presto, Nina cara, La
piccola peste e Madeline, ma quest'ultimo è pubblicato nella
Serie Bianca), da Lavinia ad Ascolta il mio cuore,
da Le streghe a Il bambino sotto vuoto, a Vampiretto,
La stanza 13 e La società dei gatti assassini, Eva
e la figlia della luna, Buchi nel deserto, Dakota
delle Bianche Dimore e L'isola in via degli Uccelli, Diario
di Anna
Frank e Marcovaldo e, infine, lassù, in cima in
cima, L'isola del tesoro. A questo punto il lettore è
formato.
Del
resto, non diversa da una scala d'oro di libri è quella di cui si
serve la protagonista di Una volta, in una casa in fiamme
di Andrea Ashworth (Feltrinelli), autobiografia piena di dolore e
di pudore che racconta come la scuola possa essere strumento di
conquista e liberazione, la più vecchia e autentica via d'uscita
dalle rovine del degrado materiale e morale, intellettuale e
sociale. Andrea, che grazie ai suoi voti alti viene ammessa al
liceo e poi all'università, legge incontinentemente e
appassionatamente, eppure gradualmente e progressivamente secondo
l'età: le favole, le storie di Enid Blyton, Il giardino segreto,
le cronache di Narnia, James e lo pesca gigante, il Diario
di Anna Frank, romanzetti rosa e horror, Carrie e tutto
Stephen King, Cime tempestose e Figli e amanti,
James, Greene, Eliot e le poesie di Dylan Thomas e Sylvia Plath.
Ma
nemmeno
lei parla di Stevenson. È un programma di educazione alla lettura
che si inerpica sopra una tassonomica scala d'oro che potrebbe
insegnare molto a non pochi insegnanti in carne e ossa. Anche qui
sembra mancare l'isola di Jim e Long John Silver, "la storia
più bella che mi abbiano mai raccontato" secondo Savater (e
anche secondo me, che tento disperatamente di difendermi con
l'ombrello). Sembra mancare, ma in realtà quel libro garantisce
la solidità e la stessa esistenza della scala, agganciandola a
valori fondanti quali "l'amicizia, la curiosità, l'apertura
mentale". Non a caso Antonio Faeti a domanda risponde che L'isola
del tesoro è il libro che porterebbe su un'isola deserta
("Sette", 1.6.2000).
FERNANDO
ROTONDO
L'isola
del tesoro, un classico irrinunciabile
Caro
Pontremoli,
ricevuto
il tuo invito sono, per prima cosa, andato a recuperare I tre
moschettieri". (L'edizione che preferisco, quella
magnificamente e doviziosamente illustrata da
Gustavino
per Rizzoli nel 1935). "Ma le due lame avevano appena
risuonato toccandosi, che una squadra di guardie di Sua Eminenza,
al comando del signor di Jussac, spuntò all'angolo del convento.
-
Le guardie del cardinale, esclamarono ad una voce Porthos
e
Aramis. - Nel fodero le spade, signori, nel fodero le spade!
Ma
era troppo tardi. I duellanti erano stati veduti in una posa che
non lasciava alcun dubbio sulle loro intenzioni.
-
Olà, - gridò Jussac venendo avanti e facendo segno ai suoi
uomini di fare altrettanto, - olà, moschettieri, ci si batte
dunque, qui? E degli editti, che ne facciamo?"
Ecco
- tralasciando il seguito dell'episodio - ci hai colto sul fatto.
Non val neppure la pena di
incrociare
le lame, a differenza dei moschettieri veri ci arrendiamo senza
combattere.
L'isola
del tesoro non c'è.
Gravissimo.
Considerando, poi, che anche per me si tratta di un irrinunciabile
classico (e volutamente non aggiungo per l'infanzia). Uno di quei
romanzi sui quali più e più volte ritornare. Se poi si pensa che
è stato illustrato da artisti quali Battaglia, Pratt, Gustavino,
Nicco, Pyle...
Non
ne abbiamo parlato? Può essere. Devo dire che l'aspetto più
piacevole della nostra tavola rotonda è stato proprio il
divagare, il chiacchierare, il ricordare, il collegare libri e
autori nell'arco di una mattinata. Ancora non capisco come
Luisella Seveso sia riuscita (e con grande bravura e sensibilità)
a trovare un filo rosso, una coerenza in tutto il nostro parlare.
In
effetti una cosa manca, e me ne rendo conto adesso grazie alla tua
giusta osservazione: sarebbe stato assai utile completare la
tavola rotonda con una sorta di "lista" dei classici.
Perché non
pensarci
adesso?
WALTER
FOCHESATO
Una
dichiarazione d'amore per L'isola del tesoro
Caro
Giuseppe,
davvero
imperdonabile sarebbe
stata
l'omissione de L'isola del tesoro se il nostro dibattito fosse
stato sui classici in generale. Ma la nostra attenzione era sui
classici italiani, sia pure con inevitabili incursioni nel
panorama straniero. Approfitto però dell'occasione per farti una
dichiarazione d'amore verso L'isola del tesoro, scritta dal
più grande narratore di storie, Stevenson, ossia Tusitala, il
mago che racconta e che ci trascina in una splendida visione del
mondo attraverso gli occhi di un bambino. Esploratore coinvolgente
e grande interprete del dedalo morale in cui era sprofondato il
XIX secolo, Stevenson con il dottor Jekyll sfidò l'ipocrisia, con
il pirata Long John Silver il pregiudizio. Il fascino che L'isola
del tesoro ha esercitato su tante generazioni è in gran parte
affidato, credo, allo sguardo di Jim: il romanzo è, infatti, la
re
gistrazione fedele di ciò che vedono i suoi occhi. Sono occhi che
tutto vedono e tutto sentono, occhi puntati sull'astuto
sanguinario Long John Silver, con cui Jim stringe misteriose e
potenti alleanze. Come il Falstaff di Shakespeare, Silver è ormai
diventato un personaggio letterario universale.
L'autore
del dottor Jekyll e Mr.Hyde, la grande tragedia moderna che
articola il dialogo dell'Io con il suo doppio, ci mette a contatto
ne L'isola del tesoro con un'altra figura di doppio che
allude a uno stretto legame tra infanzia e pirateria, incarnata
proprio dal gigante storpio Silver. All'infanzia dell'epoca
vittoriana attraversata da controlli e da ricatti Stevenson
offriva attraverso Silver - potente raffigurazione della
trasgressione e della de
risione dei divieti - gli emblemi liberanti di una stagione di
sogno ormai svanita. Mentre la ricerca dell'isola, dei tesori che
essa racchiude, l'attrazione che essa esercita, la promessa di
avventura che ogni impresa ad essa collegata suscita, tutto questo
continua ad avere un posto davvero privilegiato nel cammino di
avvicinamento all'età adulta.
Un
abbraccio
EMY
BESEGHI
Amicizie
rinforzate
Quando
si sfida qualcuno, soprattutto se dietro il convento delle
Carmelitane, quel che si chiede è soddisfazione. Emy Beseghi,
Roberto Denti, Walter Fochesato e Fernando Rotondo si sono
presentati puntualmente e oggi, qui, l'esposizione delle loro
ragioni risuona come omaggio al grande Stevenson. Una
moltiplicazione di omaggio, un'eco sorridente e luminosa, la corsa
di cerchi concentrici tra i flutti abracadabranteschi del mare
delle storie che cantano la gloria di Tusitala. Soddisfazione,
sì. E soddisfazione sia per l'omaggio a Tusitala sia per le
amicizie che dalla prova escono non soltanto salvate ma persino
rinforzate. Tutte e quattro le amicizie ne risultano rinforzate, e
davvero non saprei dire quale lo sia in misura maggiore: nutro
infatti forti debolezze per ognuna di esse, e da ognuna di esse
potrei prendere spunto per un'ennesima salmodia. Vorrei però
approfittare almeno del post scriptum di Roberto Denti per
accennare una cosa cui tengo molto. Roberto dice che bisognerebbe
essere un po' più precisi circa le Carmelitane. Sono d'ac
cordo, e mi piacerebbe. Però - e proprio pensando a Stevenson, e
al suo grande libro, e alla sua scrittura - altrettanto mi piace,
o mi è inevitabile, abbandonarmi a una sorta di bulimia
carmelitana: voglio Dumas e voglio Bernanos. Soprattutto, oltre
loro - e le rispettive Carmelitane, e non solo
voglio le Carmelitane delle montagne del Portogallo di Karen
Blixen, quelle che abitano nel suo bellissimo La pagina bianca
(in Ultimi racconti, Adelphi), perché "dove il
narratore è fedele, eternamente, inflessibilmente fedele alla sua
storia, là, alla fine, parlerà il silenzio. Dove la storia è
stata tradita, il silenzio non è che vuoto. Ma noi, i fedeli,
subito dopo aver pronunciato l'ultima parola, udremo la voce del
silenzio". Stevenson è inflessibilmente fedele alla sua
storia; con Stevenson il silenzio canta. Anche con Karen Blixen
canta; e canta con quello che io ritengo L'isola del tesoro
del Novecento, Ci sono bambini a zig zag (Mondadori) di
David Grossman.