|
Soumchi Rubrica
Leggere negli anni verdi école |
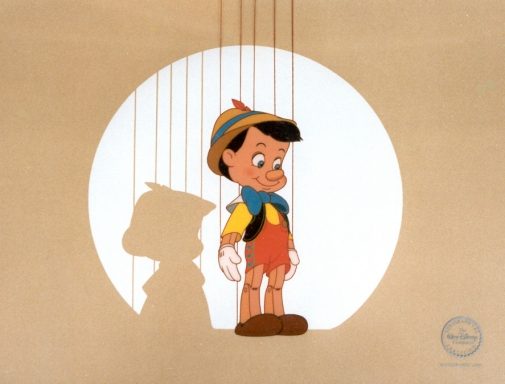
|
A
conforto della mia unmetrefischiesca statura procuro spesso di
arrivare finanche a compiacermene raccontandomi una favola esopica.
Non una a caso, beninteso, bensì una che Esopo stesso, piccolo e
deforme, immagino potesse avere particolarmente cara. Si tratta di
Giove e gli uomini,- una delle poche in cui non compaiono
animali, e tanto breve da potere esser trascritta qui per intero:
"Giove, dopo avere formato gli uomini, ordinò a Mercurio di
versare loro la intelligenza. Mercurio fece tutte le parti uguali,
e versò a ciascuno la sua. Così accadde che gli uomini di
piccola statura, cui la dose bastava a émpierli tutti,
diventarono bene intelligenti; i grossoni, invece, poiché la
pozione non arrivava a tutto il corpo, restarono i più
stolidi." Probabilmente
il Mercurio di turno ha operato in modo analogo con Israele e gli
scrittori, visto l'incredibile addensamento di questi ultimi in un
paese tanto piccolo e abitato da poco più di cinque milioni di
persone: da quello che è probabilmente il maggiore scrittore in
assoluto, Abraham B.Yehoshua, a David Grossman, da Amos Oz a
Yaakov Shabtai, da Aharon Appelfeld a Yoram Kaniuk, da Benjamin
Tammuz a Itamar Levy, da Ruth Almog a Daniela Karmi, da Yoel
Hoffmann a Savion Liebrecht, da Yehoshua Kenaz a Uri Orlev, da
Yehuda Amichai a Nathan Zach. Tra questi, alcuni sono grandissimi,
come Yehoshua, Grossman, Shabtai, Oz. Si
potrebbe pensare che questo abbia a che vedere con il fatto che il
popolo ebraico è il popolo del Libro; probabilmente si tratta
invece di qualcosa che ha a che fare con la giovane età dello
Stato e della lingua. Ha detto una volta Amos Oz: "Israele è
forse l'unico paese al mondo dove lungo tutta una generazione sono
stati i figli a insegnare a padri e madri la propria lingua". Soumchi
è un ragazzino undicenne che vive a Gerusalemme, al tempo
dell'occupazione inglese di quello che diventerà poi lo Stato di
Israele. Le vicende della Storia affiorano soltanto marginalmente,
quel che invece si dispiega abbondantemente è la storia di
Soumchi, dei suoi desideri e del loro cozzare con le logiche
inspiegabili e insormontabili della cosiddetta realtà. Soumchi si
muove sempre sul confine di ingenuità e ironia, si appassiona e
stupisce, e si cimenta La
storia si potrebbe anche raccontare con le stesse parole di
Soumchi, che ne fa una stringatissima sintesi in chiusura del
libro: "Ecco, così siamo arrivati alla fine della storia.
Posso raccontarla in poche parole. Di come una volta mi regalarono
una bicicletta che scambiai con un treno elettrico; di come
barattai il treno con un cane; di come al posto del cane trovai un
temperino e lo diedi via per amore. Ma questa non è tutta la
verità, perché l'amore c'era anche prima che dessi via il
temperino, prima che cominciassero tutti questi scambi". Però
quel che conta, in questo bel libro, più della trama, è il suo
delineare un personaggio come Soumchi, parente stretto di Tom
Sawyer e di Cik, protagonista de Il tè e l'amore per il mare
di Fazil' Iskander, ma richiamante anche personaggi della cultura
popolare come il Jack del fagiolo magico e Giufà allorché,
incuranti di uno scambio apparentemente poco vantaggioso, si
ritrovano alla fine ad esserne ben più che risarciti. Quel che
conta è la luce dialettica che si apre sui comportamenti adulti,
sul venir meno delle fantasticherie e il sopraggiungere
dell'immaginare. Quel che conta è forse, soprattutto, che il
libro si chiude aprendosi su nuove domande. |