|
Il filo di ... Ariandersen Pinin Carpi Gioco, fantasia, invenzione, per soddisfare le curiosità dei lettori intelligenti. La carica forte di un autore che ha scelto il "partito dei bambini" su Rosso Scuola - maggio 1991 |
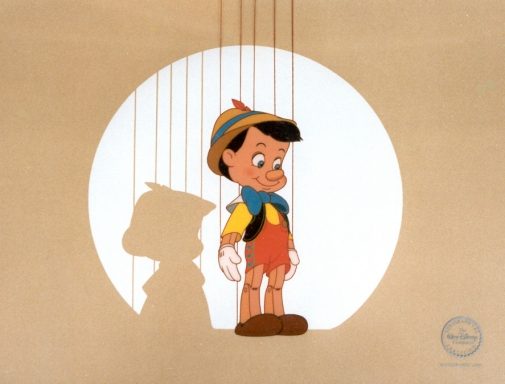
|
*************** “Guardatemi, io vengo col seguito! .:.. disse l'ago da rammendo, e si tirò dietro un filo lungo, che però non aveva nodo". Di questo ago Andersen dice subito che aveva sentimenti delicati, e che
per
questa ragione si sentiva più che altro un ago da ricamo. A me
sembra che avrebbe dovuto piuttosto parlare di spocchia, di
millanteria, di vanagloria, però non ho alcuna intenzione di
infierire su un povero ago, anche perché il fatto di trovarsi in
un racconto di Andersen - che era un bravissimo narratore - è di
per sé una condizione che assicura una dose robusta di amarezze. Quello
che mi interessa invece è che, anche nella vita di un ago, è
decisiva la questione dei nodi; e poi il fatto che, a trascurare i
nodi, si può forse finire soltanto col perdere il filo - il che
non è senza conseguenze, come tutti ben sanno, soprattutto poi se
nei paraggi Arianna non c'è. L'Arianna del mito, beninteso,
quella che diede a Teseo il filo che gli consentì di non perdersi
nel labirinto, non l'Arianna di una poesia di Pinin Carpi
contenuta in Nel bosco del mistero (Einaudi 1986), che è
soltanto una "bambina di panna / che sta in braccio alla sua
mamma / e canta tutta tutta tutta / questa bella o brutta
canzone". Soltanto una bambina. Che canta. Soltanto? Come se
fosse impresa da poco essere una bambina e cantare. E come se
fosse sufficiente avere tra le mani un filo, come se bastasse
riuscire a tornare indietro; e come se anche per cantare non fosse
necessario un filo. E allora direi che forse anche il filo di
Arianna non basta, soprattutto perché "vivere è una faéccenda
molto pericolosa" (J. Guimaraes Rosa, Grande Sertao, Feltrinelli).
Più utile, allora, del filo di Arianna, mi sembra senz'altro il
filo di Andersen. Un filo che consente sì di ritrovare la strada,
ma soprattutto di individuarne una nuova, aperta in parte dalla
scoperta della necessità di non trascurare i nodi che emergono da
L'ago da rammendo di Andersen, ma soprattutto da
quell'altra straordinaria vicenda di "sartoria" che è I
vestiti nuovi dell'imperatore. Nei
Vestiti nuovi dell'imperatore il potere si svela in tutta
la sua stupida essenza e nessuno - né chi il potere detiene, né
chi al potere è incondizionatamente acquiescente, né chi del
potere ha soltanto paura e teme forse di essere più in difficoltà
ad essere libero e pensante che sottomesso - nessuno osa dire che
quel vestito è fatto di un tessuto che semplicemente non esiste.
Nessuno, tranne un bambino; cioè chi con il potere non ha nulla a
che fare, essendone nient'altro che la negazione. Un bambino, cioè
chi con il potere non può che avere "vincoli puerili" -
e il fatto che poi l'infanzia abbia fine e si inneschino con il
potere vincoli non più puerili sarà anche qualcosa che porta a
sopravvivere e pure a vendicarsi, ma è cosa che si connota come
tristezza infinita perché altro non è che il perpetuarsi di
oppressione e calcolo, di cancellazione e silenzio. Ma
è forse preferibile sopravvivere strisciando? E’ forse
preferibile aderire mollicciamente alle gelide figure delle
colonne che reggono e sostanziano il Palazzo? Ognuno può
rispondere come vuole; a me qui preme soltanto dire che è un
problema di filo, cioè un problema politico e culturale e etico.
Seguire il filo di Ariandersen probabilmente porta anche alla
consunzione, ma è preferibile un meschino sopravvivere o il
perseguimento tenace della dignità? È un problema di filo. C'è
una bellissima affermazione di Ursula Le Guin in Il linguaggio
della notte, Editori Riuniti 1986, che mi piace riportare qui:
"Ci sono state grandi culture che non usavano la ruota, ma
non ci sono state culture che non narrassero storie".
Probabilmente Pinin Carpi la condivide perché le sue storie sono
numerosissime, soprattutto perché ogni suo lavoro è connotato
principalmente come una storia: i romanzi, i racconti, le poesie,
le ballate, i poemetti, le ninnenanne, le cantilene, le
illustrazioni, i lavori di divulgazione (dal "manuale" Alla
scoperta dell'arte, Mondadori 1983, agli otto volumi della
non-enciclopedia Il mondo dei bambini, Emme-UTET 1976 -
1980). Tutte storie, e storie dentro le storie, con decine e
decine di personaggi, seguiti assiduamente o incontrati per caso,
in forte evidenziata presenza oppure soltanto evocati, a camminare
camminare per il vasto mondo oppure accucciati in un prato tra i
rami sui tetti nel mare nell'ovunque a ridere dormire apparire
sparire cantare suonare mangiare guardare riempire il proprio e
l'altrui cammina cammina. Non so quanti possano essere, tra umani
- soprattutto bambini -, animali - soprattutto gatti -, maghi,
fate, folletti e quant'altro. Non lo so e non ha alcuna
importanza. E probabilmente il numero dei personaggi delle storie
di Carpi è cosa che può interessare teste come quelle dell'uomo
d'affari del XIII capitolo del Piccolo principe di
Saint-Exupéry, che contava le stelle per possederle, e voleva
possederle per essere ricco, e voleva essere ricco per comperare
altre stelle; oppure. a qualcuno che guardando in un caleidoscopio
si metta a contarne le immagini. Intanto
direi che non è il caso che mi sia accaduto di pensare alle
stelle e al calèidoscopio, evocazioni che forse possono dire
qualcosa di significativo rispetto alla luminosità e al profluvio
d'immagini. Questo è sicuramente un nodo, in Carpi. Tantissime
immagini, in movimento continuo, distribuite a pioggia, senza
temere alcuna possibile dissipazione. E cosi le sue storie si
configurano come in dono, come un gesto generoso preoccupato
soltanto di non essere inadeguato, di non essere esile, come il
darsi gratuito e incondizionato di chi dona soltanto per amore.
Perché questo, mi sembra, è il nodo decisivo del lavoro di
Carpi, il filo davvero sotteso: il donare - gesto, questo, che
presuppone un destinatario nei confronti del quale c'è
investimento affettivo, c'è rispetto, c'è desiderio di
contribuire a conseguire la soddisfazione del desiderio. A
me sembra che Carpi possa essere definito un autore politico, in
quanto ha individuato i bambini come propri interlocutori,
soprattutto perché disponibili sempre ad allargare il terreno del
possibile e del desiderabile, perché esseri mossi
dall'incontenibile voglia di sapere e di fare, di frugare, di
continuare a cercare; e però tutto questo, questa carica forte,
in esseri completamente privi di potere. Mi
sembra che Carpi abbia scelto senza esitazioni il
"partito" dei bambini, del loro essere senza potere, del
loro desiderio di desiderare, e abbia impostato il proprio lavoro
a far sì che i bambini possano trovarvi ascolto e rispetto e
attenzione, e attenzione ai loro desideri, e ricerca di strumenti
volti a soddisfarli. È anche per questo, direi, che ha scelto di
scrivere usando un linguaggio molto parlato, un linguaggio non
banale e non preclusivo di tempi e di luoghi ma in ogni caso
rassicurante, familiare", vicino, riconoscibile e vivo. Senza
esibire nulla, ma ben evidenziando percorsi e sviluppi ed esiti: e
ben evidenziando che gli esiti sono importanti e positivi, ma
tanto per il fatto che portano ad acquisire sicurezza e
determinare equilibri quanto per il fatto che da lì si può
ripartire. Perché ogni storia finisce, però "la storia non
finisce qui, non solo perché lì intorno cominciarono a crescere
tanti alberi che dopo un po' il lago si trovò in mezzo a un
bellissimo bosco, ma anche perché le storie, se si vuole,
continuano sempre. Basta pensarci un po' e ci si accorge che
succede proprio cosi. Questo è quello che conta di più. (La
banda del Cane Randagio, Nuove Edizioni Romane 1989). E quello
che sente anche Mauro, il protagonista di Il mago dei labirinti
(Giunti 1990), il quale, dopo aver camminato camminato per
mille e un ovunque e per mille e un altrove e avere conosciuto
"dei folletti e degli gnomi, degli elfi e delle silfidi,
delle fate e delle streghe, delle sirene e delle ondine, dei maghi
e degli spiritelli e poi dei fruncelli e degli strarli, dei
custolini e dei trumpelli, delle scorosticontine e delle
balzerotte, delle svillere e dei volpitelloni" - oltre,
naturalmente, a mille e un personaggio di varia umananimalità -
esce dai giardini della notte. E, "uscendo da quei giardini
il Mauto non era felice solo perché aveva scoperto tante cose
nuove, ma anche perché sapeva che avrebbe continuato a esplorare
tanti posti mai visti, fra gente mai conosciuta, e avrebbe svelato
tanti altri misteri arcani e proibiti, nascosti e occulti,
enigmatici e clandestini, inaspettati e incredibili". Si
cammina e cammina, e si torna, e si vuole soltanto ripartire e
tornare e ripartire e tornare, senza fine. Sempre essendo se
stessi ma sempre cambiati, come il sole. "Eccoli li, il Mauro
e Ulisse, il bambino e il leone. Sono usciti dai giardini della
notte entrano in un giardino dove il sole è appena spuntato. E lo
stesso sole di ieri, però è un sole nuovo, la sua luce è tutta
nuova, mai vista. Ed è una luce bellissima".
. Stanno
arrivando a casa, Mauro e il leone Ulisse, e davanti a loro c'è
un labirinto. Lo supereranno, non possono esserci dubbi, ma non
soltanto perché è "quello che ha immaginato, inventato,
disegnato, costruito lui, il Mauro, e che conduce alla casa più
bella di tutte, la sua casa, quella da cui senza farsi vedere da
nessuno una mattina era partito con il leone per andare in giro
per il mondo". No, non solo per questo, e nemmeno soltanto
perché sappiamo da un libro precedente (Mauro e il
leone sulla cima del mondo, Mondadori 1986) che la sua
costellazione preferita è la Corona di Arianna. LA
STRADA DEI BAMBINI NON PORTA ALLA MORALE Intervista
a Pinin Carpi Il
suo lavoro è molto articolato: racconti, romanzi, poesie,
illustrazioni. Comincerei allora da quello che è l'elemento
sicuramente unificante di tutto questo: il raccontare storie. «Pensando
al tempo trascorso, sempre più scopro che il raccontare storie ha
permeato la mia vita. A nove anni ho cominciato un romanzo, Crapotti
e Cigolini, e poi ho trovato un'annotazione, fatta quando
avevo ventun anni, in cui dicevo di avere scritto diciotto
romanzi. E una cosa sbalorditiva anche per me: ho cercato di farmi
venire in mente qualcosa di più preciso, e mi sono ricordato che
c'era Perduta nella valle,. La città di cristallo, Oltre
l'ombra, E questo vi conforti (questo titolo proviene da un verso
di Leopardi), c'era Notti d'inverno, che
consideravo una cosa molto bella. Ho scritto anche tante poesie». Non
ha cominciato subito, però, a pubblicare libri per bambini. «Ho
fatto il liceo classico e poi mi sono iscritto ad architettura.
L'architettura mi appassionava; per un certo periodo mi ha
appassionato anche la scultura; e poi l'illustrazione: nel 1941 ho
illustrato un libro di Attilio Gatti. Sono stato partigiano, e
sono stato in carcere; anche mio padre è stato in galera, è
stato a Mauthausen; mio fratello lo hanno ammazzato a Grossrosen.
Il dopoguerra è stato molto duro. Facevo il giornalista. Il primo
lavoro è stato nell'ufficio stampa del CLNAI; poi sono stato al
Touring Club, dove ho fatto dei volumi sulle regioni italiane; e
poi all'ufficio stampa dell'ACI di Milano - e pensare che non ho
la macchina e non guido... Ho pubblicato, anche nelle riviste più
inconsistenti, diversi racconti non per bambini. I primi tentativi
per bambini sono andati tutti male: ho cominciato a 14 anni,
portando una storia al Corriere dei Piccoli, accompagnato
da Bucci, un pittore che collaborava al Corriere della sera. Però
la mia storia non è stata accettata. il Corriere dei Piccoli era
molto moralistico e "educativo", anche se pubblicava
cose molto belle, Mio Mao, Fortunello, le cose di Tofano
...>> Su
Tofano vorrei che si fermasse un momento. Mi sembra che ci siano
dei legami... <<Tofano
l'ho amato prima di tutto per Bonaventura, per il suo segno
straordinariamente moderno, sintetico; erano bellissimi anche i
suoi versetti: "Qui comincia l'avventura del signor
Bonaventura ..." Scriveva con una lingua molto viva e ricca;
e poi era un grande attore, di lucidità e bravura straordinarie
anche da vecchio - e pensare che era un attore del periodo di
Zacconi, di tutti quei tromboni. Lui invece aveva un'incredibile
finezza, completamente privo di enfasi e di birignao. Tofano era
straordinario perché non solo inventava le storie, ma aveva anche
una grande inventiva verbale, giocava con le rime, con le parole
inventate; e illustrava. Secondo me, dopo Collodi, è lui il più
grande scrittore per bambini. Il suo lavoro è importante perché
non ha nulla di moralistico; Tofano non aveva intenzioni
"istruttive", "educative", Aveva un'apertura
sulla fantasia, l'invenzione, il gioco; non voleva imporre una
morale. Per me questo è stato un grande insegnamento; ed è uno
dei fondamenti del mio lavoro. lo non voglio fornire una morale.
Certo, mi importa molto del bene e del male, ho dei principi, e
questi necessariamente entrano nelle mie storie, ma non scrivo per
imporli o .trasmetterli». Un messaggio troppo esibito i bambini non lo apprezzano. Possono anche condividerlo. ma ne sentono la forzatura, ne sono infastiditi. «È
vero, i bambini lo rifiutano. Noi abbiamo delle esigenze profonde,
che richiedono anche incosciamente di essere soddisfatte: questo
appagamento i bambini possono trovarlo, secondo me, nelle fiabe. A
me sembra di avere individuato nelle fiabe un processo: le fiabe
nascono da tragedie il cui racconto con il passare del tempo si è
modificato anche per alleviare la sofferenza che conteneva e
provocava. Le tragedie si raccontano, e si raccontano" per
risolvere un problema angoscioso. Le fiabe hanno il lieto fine per
questo. Diceva
Calvino che le fiabe sono vere, che sono il "catalogo dei
destini ..." «Si,
e secondo me sono anche qualcosa di più, perché appagano tutte
le esigenze essenziali. E non è un caso che siano diffuse in
tutto il mondo; essendo i problemi comuni a tutti, servono a
esorcizzare le angosce di tutti». Quali
sono le ragioni del suo scrivere per bambini? «Perché
i bambini mi piacciono. Non scrivo per ragioni educative. Mi piace
raccontare ai bambini, raccontare loro storie che li divertano e
li spaventino anche. Questo non certo per fare loro paura, ma
perché le paure le hanno dentro e hanno bisogno di esorcizzarle,
di smaltirle. Allora è giusto raccontare storie che fanno paura,
ed è giusto e necessario che abbiano il lieto fine. Lieto fine
non significa che tutto va a finire bene, anzi, spesso è più
vero il contrario; significa invece che la vita vale la pena di
essere vissuta. I
bambini sono al di fuori del tempo e dello spazio: per loro il
tempo è ciclico, come il tempo contadino, delle stagioni, delle
feste che ritornano; per quanto riguarda lo spazio, quando un
bambino viaggia non attraversa una regione ma percorre una strada.
Per un bambino la città è la sua casa, la sua strada, i suoi
amici. E poi i bambini sono curiosi, ed è solo quando si è
curiosi che si è vivi - e pensare che ho visto degli albi per
insegnare ai bambini a non essere curiosi ... Io credo di avere
capito una cosa: che in realtà la valutazione dell'importanza,
dell'interesse, dell'intelligenza, della sensibilità, di quello
che si fa, grandi o bambini, è tutto un problema di potere. Il
bambino, che non ha nessun potere, è incapace, stupido, non
capisce niente; e invece le scoperte della scienza ci dicono che
nel bambino c'è tutta la potenzialità dell'intelligenza completa
- che poi naturalmente deve essere attivata, perché ai bambini
manca la conoscenza, mancano i rapporti tra 1e varie esperienze. lo
ho scritto pensando ai miei figli, cercando di scrivere qualcosa
che corrispondesse ai loro desideri. In questo modo ho scoperto
una cosa importante, che è anche diventata una cosa per cui ho
dovuto combattere: il diritto e la necessità di usare il
linguaggio che uso parlando, compresi gli errori. Se io, milanese,
dico "il Mauro", devo scrivere "il Mauro". Non
uso un linguaggio povero o primitivo, ma quello che uso parlando,
anche perché questo è l'unico che i bambini conoscono davvero e
col quale si sentono a loro agio. Per il miei figli ho sempre
inventato, raccontato e scritto delle storie, e verificavo con
loro quello che funzionava e quello che invece andava tolto o
cambiato. Poi ho cominciato ad andare nelle scuole, e inizialmente
avevo un po' paura; ma anche lì verificavo quello che funzionava
e quello che invece non andava. E ho capito sempre più che quello
che era necessario era il raccontare storie che rispondessero ai
loro desideri e fossero parlate». Per
quanto riguarda la nostra lingua parlava di Collodi e Tofano. E in
aree linguistiche diverse? «Secondo
me il primo grande scrittore per bambini è stato William Blake,
che ha scritto i Canti dell'innocenza, che sono una
meraviglia. Ho amato moltissimo Andersen: rileggendolo ho
ritrovato cose straordinarie, insieme ad altre inaccettabili e
meno adatte ai bambini. Per esempio, quando parla di bambini buoni
e bambini cattivi io non sono per niente d'accordo: i Bambini non
sono né cattivi né buoni, possono diventare gli uni o gli altri
a seconda degli adulti che fanno loro da modelli. Altri autori
molto amati sono quelli della letteratura inglese, da Lear a
Carroll a Barrie». E
relativamente all'attività di pittore e iIIustratore? Quali amori
e maestri? «Sicuramente
Rackham, Dulac, Dorè. Ho sempre avuto una grande passione per gli
illustratori inglesi, ma soprattutto per Arthur Rackham. Ho amato
moltissimo la pittura cinese e Broeghel, con quelle grandi scene
fitte di cose - mi ha sempre incantato. E poi, soprattutto per il
fatto di essere figlio di un pittore, ho assorbito un'infinità di
immagini. Vedevo continuamente pittori, andavo nei loro studi,
alle mostre, alle gallerie. Avevo dodici anni e mi hanno portato a
Siena, dove ho visto i resti smozzicati di un'opera di Jacopo
della Quercia e me ne sono innamorato. Da tutto questo è derivata
anche l'idea della collana, che ho inventato, "L'arte per i
bambini" della Vallardi. Lavori
in corso e prossime uscite? «Uscirà
una raccolta intitolata La zia Corsara all'osteria e altre
storie insensate; è una serie di storie di nonsense che
pubblicherà Giunti. Poi c'è un romanzo, Il romanzo della
magia, che è illustrato da fotografie; è una storia
irlandese, nata da un viaggio in Irlanda con mio figlio e dalle
fotografie che in quel viaggio mio figlio. ha fatto». Anche
Le lanterne degli gnomi proveniva da suggestioni irlandesi;
e complessivamente, nel suo lavoro, si avverotono riferimenti
nordici. «Nella
mia infanzia e nella adolescenza ho amato moltissimo Andersen e
tutta la letteratura nordica. Da ragazzo, per me, Dickens era il
più grande scrittore del mondo. Quando ho letto, a tredici anni, Oliver
Twist, sono rimasto sbalordito. Leggevo ai miei amici Alice
nel paese delle meraviglie. Il versante nordico mi ha
affascinato molto. Devo dire che mia madre, da ragazza, con sua
madre e sua sorella, traduceva una rivista inglese, forse di moda,
ed è sempre rimasta molto legata alle cose inglesi, aveva molti
libri inglesi. E io gli inglesi li ho anche amati molto perché
erano odiati dai fascisti. Poi ho amato molto Kipling, Chesterton,
Stevenson; e i poeti, da Shakespeare a Shelley a Keats a Tennyson
a Wordsworth, Browning soprattutto, fino ai più recenti, Yeats,
Eliot». Non
è prevista un'altra raccolta di versi? «Materiale
ne ho tanto, ma il problema vero è il tempo. Vorrei anche
dedicarmi alla saggistica. Ho molto materiale, molti appunti, per
esempio sulla fiaba, o sugli amici invisibili dei bambini. I
bambini sanno benissimo che questi amici invisibili non esistono,
ma ne parlano continuamente e se ne servono come se esistessero
davvero. Secondo me è un po' come l'opera d'arte: è una realtà,
anche se tutti sanno che non esiste. Un dipinto è carta sporcata
di pastello, però quando si guarda è una realtà vitale, molto
importante. Questa capacità dei bambini di creare con la mente
delle realtà che non esistono, sapendo che non ci sono ma
vivendole come se esistessero, secondo me è qualcosa come la
nascita della necessità dell'arte».
|