|
Cammina cammina, in cerca di avventure per la nostra felicità L'opera saggistica e narrativa di Beatrice Solinas Donghi su Rosso Scuola gennaio-febbraio 1991 |
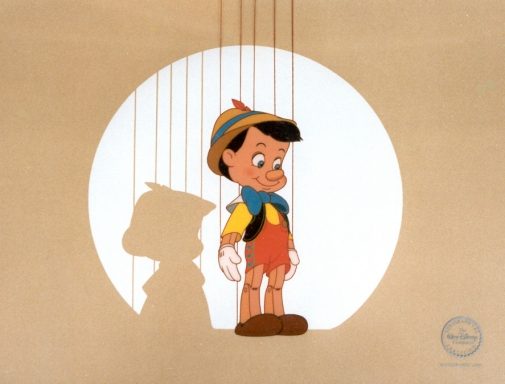
|
*********************** Se dicessi d'avere, a tutt'oggi, molto ma molto errato, direi soltanto il vero: pertanto lo dirò. Ma il dire presuppone - o non lo presuppone, ma poi ci incappa dentro - il farsi intendere, e allora
entrano in gioco mille cose e finisce che poi
cascano gli asini. Dato
che tengo molto all'incolumità degli asini e che tra quelle mille
cose so bene esserci anche l'esistenza di benevoli e malevoli, la
secca verità non sarà sufficiente. Infatti, se dico d'avere
molto errato, subito e ciecamente i benevoli mi riterranno
erratico, i malevoli erroneo. Il vero invece è questo: hanno
ragione entrambi, ed entrambi hanno torto, avendo io molto errato
erratico ed erroneo. Del mio essere erroneo, però, qui vorrei
solo tacere -ché ci sono altri luoghi più acconci alla bisogna -
e vorrei dire
invece dell'errare erratico. Nessuno si spaventi: non parlerò dei
miei viaggi, anche perché non mi riesce difficile riconoscermi,
ben più che nel ruolo di avventuriero attivo, in quello di
avventuriero passivo, «ruolo che consente il piacere di
avventure meravigliose senza che ci si debba sottoporre agli
inconvenienti e alle sanzioni divine e sociali che esse comportano»,
come spiega Pierre Mac Orlan nello squisito Piccolo manuale del
perfetto avventuriero, Tusitala 1986. Il
mio stato di avventuriero passivo non mi ha però impedito, per
diverse ragioni che qui non interessano, di errare parecchio,
cambiando piuttosto spesso abitazione. E così m'è accaduto di
avere numerosi vicini: generalmente, a prescindere da certi
ululati che si regalano in famiglia, dentro i loro appartamenti,
persone educate e corrette. Quelli attuali, per esempio,
incontrati per le scale salutano, e sono anche in grado di dire se
quel giorno faccia molto caldo oppure molto freddo, quanto abbiano
impiegato a parcheggiare o, nei giorni di pioggia, quanto piova. E
casi cambierò casa ancora; non mi piace avere cattivi vicini.
Perché questi altro non sono che tali: dice infatti Peter Bichsel
che un buon vicino è uno che racconta qualche cosa, al
contrario di uno che dica qualche cosa. Si potrebbero fare,
a questo proposito, molti discorsi, si potrebbero dire molte cose;
io mi limiterò a ricordare quale forza vitale indistintamente ci
sia nel narrare se Shaharazàd, per mille e una notte, salva la
propria vita raccontando; mi limiterò a ricordare questo e a
raccontare una storia. È una storia chassidica, ricordata da
Gershom Scholem in Le grandi correnti della mistica ebraic,. (Il
Saggiatore 1965), che trascrivo qui con le parole che Scholem
affermava di avere riportato dalla viva voce di Shemuel Yosef Agnon:.
«Quando Bàal Shem [che fu il mistico fondatore del chassidismo)
doveva assolvere un qualche compito difficile, qualcosa di segreto
per il bene delle creature, andava allora in un posto nei boschi,
accendeva un fuoco, diceva preghiere, assorto nella meditazione: e
tutto si realizzava secondo il suo proposito. Quando, una
generazione dopo, il Maggid di Meseritz si ritrovava di fronte
allo stesso compito, riandava in quel posto nel bosco, e diceva:
"Non possiamo più fare il fuoco, ma possiamo dire le
preghiere"- e tutto andava secondo il suo desiderio. Ancora
una generazione dopo, Rabbi Moshè Leib di Sassow doveva assolvere
lo stesso compito. Anch'egli andava nel bosco, e diceva: "Non
possiamo più accendere il fuoco, e non conosciamo più le segrete
meditazioni che vivificano la preghiera; ma conosciamo il posto
nel bosco dove tutto ciò accadeva, e questo deve bastare". E
infatti ciò era sufficiente. Ma quando di nuovo, un'altra
generazione dopo, Rabbi Ysra'èl di Rischin doveva anch'egli
affrontare lo stesso compito, se ne stava seduto in una sedia
d'oro, nel suo castello, e diceva: "Non possiamo più fare il
fuoco, non possiamo dire le preghiere, e non conosciamo più il
luogo nel bosco: ma di tutto questo possiamo raccontare la
storia". E il suo racconto da solo aveva la stessa efficacia
delle azioni degli altri tre». Un
pozzo nel mondo. C'è
un pozzo, nel mondo, e ha pure una certa capienza, al quale si
potrebbe tutti quanti attingere per fornirsi di strumenti per
affrontare qualche compito difficile e avere di che salvarsi la
vita per ben più che mille e una notte. È l'insieme, sterminato
davvero, di tutte le storie, d'ogni tempo e paese. Per esempio,
non dice proprio nulla ad arabi e israeliani a proposito del loro
essere in conflitto il fatto di avere nei rispettivi patrimoni
culturali le due storie che qui ricorderò? In
un racconto popolare arabo a Giuha viene rubato l'asino. Allora si
mette a correre e gridare minacciando che, se non gli verrà
restituito,<<"farò come ha fatto mio padre!"
Spaventati, i ladri stavano per restituire l'asino, ma uno di loro
domandò: "Che cosa ha dunque fatto tuo padre?" "È
semplice" rispose Giuha "ne ha comprato. un altro'>>(Racconti
popolari arabi, a cura di E. Console, C. Gutermann e S.
Villata, Mondadori 1985). E in una delle Storielle ebraiche (a
cura di F. Folkel, Rizzoli 1988) si racconta che a un mercante
ebreo viene rubato il cavallo mentre si trova in una locanda.
Quando scopre il fatto si mette a gridare: «"Guai a voi
miserabili (...) Mio padre mi ha insegnato che cosa fare in questi
casi". Il vecchio Mendel, terrorizzato, gli si avvicina e gli
chiede: "Ma che cosa ha fatto suo padre?" "Che cosa
ha fatto? Se ne è andato a piedi"». Significherà
pur qualcosa il fatto che esistano, nella storia delle storie di
due entità che cercano di distruggersi a vicenda, ed esistono in
entrambe, due situazioni immaginative, memoriali, narrative,
comportamentali, emotive, sociologiche, culturali, tanto vicine.
Troppo semplice? Forse si, ma proprio questo dovrebbe costituire
l'incentivo decisivo a tenerne conto. E invece mica se le
raccontano le loro storie; non si raccontano nulla: pessimi
vicini. Questi
«esempi» potrebbero anche essere come qualche cosa che
equipara il raccontare a qualche altro agire umano e anzi qualche
volta a questo «altro agire» si sostituisce. Lascio a chi voglia
farlo di prendere alla lettera la faccenda; l'intento mio è
invece d'altro tipo. L'intento mio è quello di sottolineare
quanto utile potrebbe derivare dal praticare il «dilettevole»,
nella convinzione che, come diceva Leopardi; «il dilettevole sia
più utile che l'utile». Ma, se il raccontare può salvare la
vita, mutare l'essenza dei rapporti tra vicini, provocare il
sospetto di una possibile profonda fraternité tra coloro
che passano la vita a perseguitarsi, perché non assumere
del raccontare i «luoghi privilegiati» -
le storie -
prima di
tutto in quanto storie, racconti di vicende, luoghi di affascinato
incantamento? Beatrice
Solinas Donghi, una quindicina d'anni fa, ha scritto un libro
molto bello e molto importante, La fiaba come racconto. In
questo libro, limpido e profondo, giustamente polemico e
appassionato, Solinas Donghi ha rivendicato la necessità di
restituire alla fiaba il maltolto. Troppo a lungo, ripetutamente,
con reiterata ostinazione, ci si è serviti delle fiabe per
cercare in esse «spiegazioni» che tutto consideravano tranne la
loro essenza prima, il loro essere appunto innanzitutto un
racconto; con il risultato di ridurre la fiaba a chiave
interpretativa unidirezionale: arrivando così a un impoverimento
oggettivo, a fronte della prodigiosa ricchezza di possibilità di
lettura che il racconto in sé contiene e che ognuno deve trovare
da sé, se lo vuole. Un'eco
creativa Contro
queste impostazioni Beatrice Solinas Donghi non ha però
scritto soltanto quell'importante libro di saggi -
oggi purtroppo non
più disponibile -; il suo discorso si era avviato in precedenza
ed è proseguito fino a oggi attraverso le sue storie, le sue
fiabe e i suoi romanzi. Le sue narrazioni, mai ispirate ad una
finalità dimostrativa di messaggi più o meno esibiti, si
sviluppano all'intemo di una frequentazione assidua e lieve dei
luoghi canonici della fìaba, soprattutto a partire dalla
tradizione popolare. Una frequentazione assidua e lieve,
profondamente assorbita, assimilata, è come rilanciata in una
continuità che si innesta su temi e linguaggi
senza travisamenti e nello stesso tempo con sviluppi -
di temi e di
linguaggio - che
non ne fanno una stanca ripetizione ma
al contrario qualcosa come una sensibile eco, un'eco che
non si contenta di rinviare il già emesso da altri. È un po'
come se si trattasse di un'eco che alla riproduzione di un suono
ricevuto accompagni una propria voce, di quel suono
mantenendo integro il timbro ma nello stesso tempo rielaborandolo
e restituendolo rinnovato. Non si tratta di banali aggiornamenti
di linguaggio, non si tratta di inserimenti di oggetti e
personaggi dei nostri giorni; si tratta piuttosto di
calibratissime vibrazioni, di sapienti spostamenti minimi, operati
quasi con pudore ma con forza semplice e quindi vera. Si
potrebbero prendere le fiabe di Beatrice Solinas Donghi e cercare
in esse i riferimenti, i rimandi, le citazioni di luoghi,
situazioni, temi e motivi della fiaba popolare; si potrebbe
cercare in esse tutto questo e si scoprirebbe che molto ma molto
resterebbe comunque ancora, elaborato con eleganza sottile, e con
altrettanto sottile ironia. Questa
impostazione di ripresa di motivi della fiaba tradizinale aveva
avuto due felicissimi esiti nella Gran fiaba intrecciata e
nelle Fiabe incatenate; ma anche nel recentissimo Le storie
di Ninetta questa impostazione ritorna, cosi come ritorna il
principio di fornire una serie di storie che, pur in piena
autonomia e pienamente fruibili singolarmente, formano un insieme
complessivo, una storia sì articolata in parti ma fortemente
unitaria. E sostanzialmente succede un po' questo: si leggono le
singole storie, e queste si rivelano piacevolissime e vive; ma
leggendo l'intero libro si ha un ulteriore incremento di
piacevolezza, dovuto al fatto che il legame fra le parti della
storia è tanto lieve ma saldo da costituire di per sé
un'attrazione. Quando,
qualche anno fa, uscì Quell'estate al castello, il romanzo
fu accolto evidenziando un felice ritorno del «romanzo per
ra.gazzine». In effetti si tratta di un libro che si colloca in
quel filone, con una precisa parentela con i romanzi che uscivano
nella «Biblioteca dei miei ragazzi» della Salani. Si tratta però
a mio parere di qualcosa di più: un romanzo di ragazzine,
ricco di avventure e vicende raccontate con ironia leggera, con la
giusta dose di mistero e con un'attenzione alla dimensione della
memoria che ne fa anche un utile strumento di conoscenza di un
tempo diverso dal presente. Questo fa si che il romanzo sia molto
fruibile non soltanto dalle «ragazzine» ma anche dai ragazzini e
dagli adulti. Perché queste ragazzine non sono sdolcinate eroine,
sono piuttosto personaggi «veri», forti del disponibile e
partecipe e allegro e doloroso sentire. Allora anche le avventure,
tante e avvincenti, si rivelano essere poi qualche cosa di più;
si rivelano essere l'accompagnamento e il contorno di altre
avventure, le avventure interiori - e allora, forse, è anche
necessario che di ragazzine si tratti, essendo queste
fornite di un di più di sensibilità rispetto agli adulti
e ai ragazzini -. E questo non vale soltanto per le protagoniste
di Quell'estate al castello, ma anche per Peonia e Fenice,
ne La figlia dell'Imperatore. E non solo; anche Ninetta, la
protagonista di Le storie di Ninetta, è un personaggio che
appartiene al piccolo popolo delle bambine avventurose e sagge,
disponibili e quietamente ma tenacemente determinate. Delle
bambine che si sanno stupire e appassionare, e perseguono con
costanza stupori e passioni; delle bambine serie e sorridenti che
capiscono subito che tipo sia l'Uomo Selvatico e sanno
interpretare la sua ostica lingua; delle bambine gentili e tenaci
e che proprio per questo vengono scelte dalla Gattaferra per
svelare loro la propria caratteristica di gatta parlante e per
aiutarle contro le insidie del gerolamese, la perfida trappola del
rude zio Gerolamo. Delle bambine, insomma, che camminano
camminano, e vivono avventure per la felicità degli
avventurieri passivi. I quali errano molto, erratici ed erronei e,
pur continuando probabilmente a ripetere errori e farne pure dei
nuovi, sarebbero felici di fermarsi in una casa in cui trovare un
ottimo vicino come Beatrice Solinas Donghi, narratrice di storie. |