|
L'opera di Giuseppe Pontremoli tra nonsenso e dissenso di Anna Meta su Il pepe verde n.21 2004 |
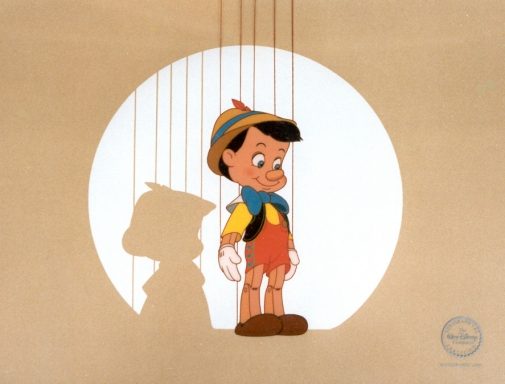
|
Come
alla fine della vita, quando una persona rimane incantata: ne
rimane la storia nella memoria di chi è ancora qui, (Giuseppe
Pontremoli, Il mistero della collina). *************** Giuseppe Pontremoli, scomparso il 9 aprile 2004 a soli 48 anni (era nato a Parma nel 1955), è considerato uno degli scrittori per ragazzi più fini del Novecento. È stato un maestro elementare, ha studiato con passione e attenzione le questioni legate ai temi della lettura, la narrazione orale, la letteratura per l'infanzia. Ha studiato inoltre le rappresentazioni dell'infanzia nella letteratura, le uniche dove sia possibile scorgere i bambini come innumerevoli singolari e non il Bambino come è rappresentato nei trattati di Pedagogia. È stato un insegnante e uno studioso diffidente verso i Bambinologi e ha preferito affidarsi a chi si era accorto dei bambini guardandoli per davvero e guardando le cose loro intorno. Dunque la sua preferenza si rivolgeva a EIsa Morante, Tolstoj, Bilenchi, Henry Roth, Don Milani, Guimaraes Rosa.
Ha collaborato con varie riviste, tra cui "Linea
d'ombra" e "École", ha scritto saggi, poesie e
romanzi per ragazzi. Un'attività vantaggiosa
È stato consapevole di meritare il biasimo da parte dei ben
pensanti per alcuni suoi modi di fare, ad esempio non resistere
all'impulso irrefrenabile di voltarsi a guardare i bambini, perché,
nonostante avesse a che fare con loro ogni giorno, grande era il
desiderio di osservarli muoversi in tutti gli spazi, nei loro
gesti, ascoltarli nel loro passare da una domanda all'altra,
guardarli, rapportarsi alle cose loro intorno per intrecciare il
dentro e il fuori. Si è voltato a guardarli nei libri
inseguendoli nel loro cammina cammina dentro i racconti e i
romanzi. Riteneva questa attività vantaggiosa per almeno due
ragioni. La prima, da ravvisare nella capacità di rappresentare
l'articolatezza dell'infanzia da parte di grandi scrittori che
possiedono una visione dinamica di questa età, la ritroviamo
nelle pagine di Melville, Faulkner, Twain, per citare solo alcuni
tra gli autori molto amati da Pontremoli. La seconda ragione per
giustificare il guardare nei libri viene avvalorata dalla
possibilità che ci si dà di leggere storie che finiscono col
donare al lettore un piacere. Risultato apprezzabilissimo,
sostiene Pontremoli, il quale sottoscrive il parere di Auden nel
ritenere il piacere lontano dall'essere un criterio critico
infallibile, ma sicuramente è il meno ingannevole.
Un'altra tra le azioni riprovevoli da lui compiute è stato
esaltare la lettura di libri e il raccontare storie inventate. Di
questo suo entusiasmo ne troviamo una testimonianza nel suo
intervento nell'antologia Leggere gli anni verdi, curata da
lui insieme a Cesare Pianciola per le Edizioni e/o, e nell'ultima
opera Elogio delle azioni spregevoli, pubblicata dalla casa
editrice L’ancora del Mediterraneo, il cui titolo riprende il
duro giudizio di un personaggio letterario, il signor Gradgrind di
Tempi difficili di Dickens, sul leggere i libri e il
raccontare storie di fantasia. Per questo personaggio solo i fatti
rappresenterebbero l'unico vero bisogno della vita, tanto da
indurlo ad ammonire sua figlia con la raccomandazione «non
immaginare mai!». Nutrirsi di storie sembra a molti un esercizio
vuoto, senza valore, soprattutto sul piano degli apprendimenti,
eppure, sostiene Pontremoli, mentre riporta ad esempio una
citazione da Dostoevskij, le storie possono contribuire a
costituire durante l'infanzia uno scrigno cui attingere anche in
futuro. Perfino ciò che appare gratuito, improduttivo, insensato
può servire. Le filastrocche, afferma, sono insensate, eppure
servono. I bambini spesso riescono a fare fronte alle paure
servendosi delle filastrocche che, abitando nel nonsenso, sono
imparentate con il dissenso. Per questo consentono aperture che
introducono nella dimensione del mutamento e dell' inventiva.
Raccontare storie ai bambini, cioè aiutarli a crescere, aiutarli
a imparare a vivere è l'impegno di Pontremoli. I bambini hanno
bisogno di storie come hanno bisogno di cibo. Il bisogno di storie
è universale, a dimostrazione cita una frase tratta da un saggio
di Ursula K. Le Guin: «Ci sono state grandi culture che non
usavano la ruota, ma non ci sono state culture che non narrassero
storie».
Le narrazioni permettono di intravedere le possibilità del
cambiamento prospettate nei racconti. Ma al di là del
racconto deve essere presente una passione vera che abbracci il
senso stesso della propria esistenza, una passione da mantenere
viva e da alimentare continuamente. E Pontremoli, anche se conosce
i motivi veri e profondi che conducono a fare i conti con la paura
e la gioia di leggere, non si limita a prescrivere il balsamo,
dimostra invece come occorra essere sinceri per invogliare a
leggere, comunicare il forte sentire che viene dalla portanza
delle storie. Racconta di praticare con i suoi alunni l'azione
spregevole di leggere insieme libri e della complicità che viene
a crearsi nel gruppo, naturalmente l'aiuto viene dalle belle
storie. La
Storia e le storie
Pontremoli è consapevole d'imporre le sue scelte ai bambini, sa
che per contagiare i suoi ascoltatori deve essere sincero, deve
mostrare di sentire i libri dai quali individuare le proprie
proposte da porgere. Faceva parte di quella schiera di adulti di
un tempo che, come ricordato da Faeti in La bicicletta di
Dracula, non si tiravano indietro nel rendere partecipe
l'infanzia del loro mondo, dei loro miti, dei loro sogni,
avvalendosi nella comunicazione di solide attrezzature
metaforiche. Si dichiara orgoglioso di non aver mai utilizzato le
letture e i racconti presentati agli alunni per qualsiasi forma di
esercitazione scolastica. Ha soltanto offerto ai bambini la
possibilità di parlare molto dei racconti e di quello che questi
racconti provocavano in loro. La pratica della discussione per lui
- diffidente verso i lavori organizzati con tutte le dovute
articolazioni, con obiettivi didattici da conseguire - conduce
sicuramente a risultati meno banali di quelli ottenibili con i
lavori da eseguire all'interno di un tempo scolastico segmentato,
nel quale viene tolta la possibilità di fluttuare in tutta calma
e di fatto diviene un atto contro la lettura.
Tra gli autori di libri per ragazzi proposti nel saggio sentiamo
di citare Stevenson, Rushdie, Twain, D'Arzo, Orlev, Hughes,
Collodi, ma, come già evidenziato da altri, mancano tra le
proposte i libri per ragazzi degli scrittori contemporanei più
affermati e apprezzati. Pontremoli non giudicava positivamente
questi autori? Probabilmente la sua sincerità di educatore e di
appassionato amante delle storie lo ha spinto prevalentemente alla
ricerca di condivisione e di comunicazione di sue esperienze di
lettore e per fare questo poteva utilizzare solo i testi più
vicini al suo sentire.
Anche il tempo della Storia, la politica interferiscono
inevitabilmente con le vite dei bambini. La Storia finisce con
l'interferire anche con la letteratura per l'infanzia, diviene
indispensabile. Sostiene Pontremoli nel capitolo "Della pace
e della guerra" di Elogio delle azioni spregevoli, che
la Storia non soppianti le storie, anzi queste ultime dovrebbero
illuminare la Storia se sono storie in grado di suscitare nuove
domande, senza limitarsi a fornire risposte. Tra gli esempi
riusciti di libri in cui la Storia è esplicitamente presente
richiama L'isola di via degli uccelli di Uri Orlev, La
donna di ferro di Ted Hughes, Rosa Bianca di Roberto
Innocenti, Il prigioniero del Caucaso di Tolstoj, quindi
libri che esprimano il bisogno di racconto, di invenzione, di
ricerca, di scoperta, di apertura.
«C'è bisogno di storie. Storie che facciano sospettare di avere
a che fare con il cosiddetto reale, non già che pretendano di
rivelarlo. C'è bisogno di storie caratterizzate dalla lingua,
dallo spessore simbolico, dall' eco risonante nelle cavità
interiori.» Allora il valore delle storie con un esplicito
riferimento alla Storia non deve essere ricercato nell'adesione al
reale, nel politicamente corretto.
Analogamente Pontremoli avverte che bisogna diffidare anche di
quegli altri libri bene intenzionati, concepiti per suscitare
buoni sentimenti, con l'intento di avvicinare i bambini all' amore
per la natura e a impegnarsi per la sua salvaguardia, ma
generalmente privi di quello spessore da cui trarre il senso della
presenza umana sulla terra e dei rapporti che intercorrono tra
tutti gli esseri e gli elementi che la abitano. Si può in questo
caso pensare solo a "storie boscose", storie anch'esse
dotate di una forte carica simbolica, caratterizzate soprattutto
dall'essere scritte "in una lingua dignitosa", che
dimostri di essere utilizzata da qualcuno che consideri i bambini
persone da rispettare. Estetica
deI libro
La diffidenza di Pontremoli tocca tutti quei libri, costruiti ad
hoc, dedicati a i problemi: mafia, droga, inquinamento, pace,
anoressia, ecc. Libri nati per esigenze di mercato e per fornire
alibi alla pigrizia dei docenti. I problemi importanti dovrebbero
essere sviluppati all'interno di storie che nascono da esigenze
dell'arte. Ancora una volta rimane l'esigenza di toccare le corde
profonde. Questo secondo Pontremoli è il punto di partenza per un
cammino insieme, docenti e discenti, lungo i percorsi
dell'immaginare e del dire, attraverso il quale si può costruire
uno strumento autentico per affrontare i problemi reali.
L’interrogativo «Chi sono io?», che si pone, si ripropone, e
si impone a tutti noi, gli dà l'occasione di parlare dei romanzi
di formazione, romanzi punteggiati di passaggi che si presentano
ogni volta come nuove iniziazioni. Romanzo di formazione è per
Pontremoli Le avventure di Finocchio, dove Collodi mette in
scena una concezione tragica dell'infanzia e della sua alterità.
Il libro dovrebbe essere conosciuto subito da tutti e essere
ripreso più volte, ma sempre nella sua integrità e non
attraverso riduzioni e adattamenti. Anche L'isola del tesoro è
un susseguirsi di passaggi. Il protagonista Jim Hawkins, al pari
di Pinocchio, passa attraverso il susseguirsi di continue scoperte
del lato oscuro della realtà. A questi due libri viene accostato Ci
sono bambini a zig zag di David Grossman, che Pontremoli
definisce L'isola del tesoro del Novecento, con anche il
pregio di presentare tre straordinarie figure femminili. Il valore
di questi grandi libri iniziatici, difficilmente contenibili nelle
definizioni "per bambini" o per "ragazzi" è
di essere grandi «anche perché, pur chiudendo perfettamente i
loro cerchi, non chiudono orizzonti, non forniscono soluzioni
secche», continuano invece a far germinare domande. Pontremoli si
è anche cimentato come narratore per ragazzi. Il romanzo Il
mistero della collina, pubblicato da Giunti, è costruito
seguendo lo schema di una storia gialla i cui indizi confusi si
ricostruiscono man mano che si procede con il racconto. Presenta
due voci narranti che si alternano, una, in terza persona, narra
lo svolgimento dei fatti, l'altra voce irrompe in prima persona in
modo più irruente, soffiando elementi e riflessioni sparse. Il
racconto raccoglie e ricompone tutti i temi cari all'immaginario
di Pontremoli: storie riprese dalle tradizioni orali di altre
culture, il valore della memoria e delle storie, il vento,
l'omaggio agli scrittori Silvio D'Arzo e Joao Guimaraes Rosa.
Le pagine di Pontremoli sono difficilmente riassumibili per la
quantità di spunti di riflessione ricchi di bagliori che ci
offrono. Dai suoi scritti si staglia la figura di un maestro che
si è assunto la responsabilità di agire la propria parte perché
erano i ragazzi a chiedergli una presenza viva alll'interno
dell'accadere. La dimensione pedagogica entro la quale si è
espresso è stata quella di Don Milani e di Pasolini, per lui tra
i pochi pedagogisti italiani con cui era veramente necessario
confrontarsi. È la scelta di una dimensione che evidenzia come
valore l'effettivo mettersi in gioco in tutta la propria
interezza.
Il forte sentire che Pontremoli ci ha testimoniato, la ricerca
dell'essenzialità più intima e vera - di cui ci piace pensare
che gli venissero dall'essere cresciuto camminando tra l'intrico
degli alberi dentro il bosco e dal suo amore per
l'incontrollabilità del vento - ci indicano la strada per la
scoperta del valore delle storie e della memoria. È un percorso
affascinante anche se sempre più difficile oggi nel nostro
orizzonte povero e limitante, costellato da vuote insegne roboanti
e da individui persi nell'inseguimento dell'ennesimo feticcio. |