|
Storie proprio così da ècole 1 2001 |
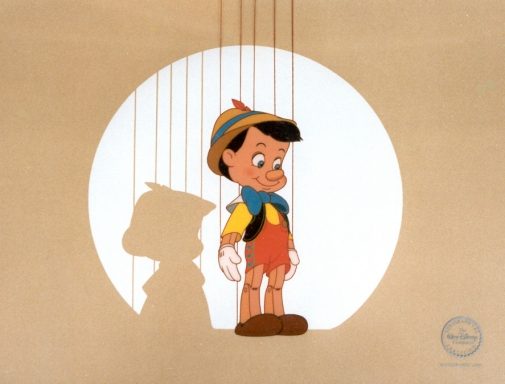
|
Come
tutti ben sanno, ciascuno ha i proprii riti, più o meno confessabili.
Anch’io, naturalmente, e d’uno, che non solo ritengo confessabile
ma addirittura mi rende in qualche modo orgoglioso, voglio dire qui.
Da trent’anni, al cambio dell’anno, rileggo la New
Year Letter (Lettera per il
nuovo anno) di W.H.Auden. Sì, trent’anni. Ne avevo quindici, proprio appena compiuti, quando la lessi per la prima volta. Qualche tempo prima, nell’estate, in un libro di mia sorella maggiore avevo letto una
poesia di Auden che mi aveva molto colpito e mi aveva messo dentro il
tarlo di leggerne altre, ancora e ancora. Potei farlo solo
nell’autunno inoltrato, un pomeriggio di fine novembre, quando
riuscii, dopo molti tentativi andati a vuoto, a vincere il timore che
alla Biblioteca Palatina di Parma non mi facessero entrare perché non
avevo ancora sedici anni. Quel pomeriggio percorsi ancora una volta lo
scalone, poi entrai. Sbirciando i gesti altrui mi riuscì di capire
dove fossero i cataloghi, cosa si dovesse compilare. Intanto facevo
mentalmente danze propiziatorie, e soprattutto facevo prove mentali
perché la voce uscisse bassa e piena, senza stridulerie da ragazzino.
Non ebbi bisogno di usarla, la voce; l’addetto alla distribuzione
prese la mia scheda senza chiedermi nulla e dopo un po’ mi consegnò
due libroni: Opere poetiche
di W.H.Auden. Frugavo avidamente in entrambi, spesso senza capirci
molto, e copiando disordinatamente su un quaderno intere poesie e
singoli versi. Quando incappai nella Lettera
per il nuovo anno capii che non sarei riuscito a leggerla tutta.
Si stava avvicinando l’ora in cui, qualora fosse riuscita a vincere
la solita trattativa con sua madre, Anna mi avrebbe aspettato alla
fermata dell’autobus davanti al monumento al Partigiano. Volevo
continuare a leggere, e mi andavo dicendo che Anna non ce l’avrebbe
fatta, ma avevo troppa voglia di vederla, troppe cose da dirle, troppe
emozioni da mettere in comune, e quei versi da leggerle. Prima di
volare da lei, trascrissi anche i primi versi della Lettera: «Sotto il peso familiare / dell’inverno, della coscienza
e dello Stato, / in formazioni sparse di allegria, / linguaggio,
amore, solitudine e paura, / verso le abitudini del prossimo anno, /
la folla scorre lungo le strade, / cantando o sospirando nel suo
andare». Andammo subito al Parco Ducale, e la nebbia era quella di
sempre, e la luce sempre quella fioca, e i baci e le carezze erano
quelli di sempre, e il tempo sempre il solito maledetto avaro, ma le
mie parole erano i versi di Auden, che le leggevo tenendola stretta,
il quaderno dietro i suoi capelli, dentro uno stordimento, in una
miscela di beatitudine e ansia.
Chissà cosa capii, quella volta, di
Auden? (Non è propriamente una lettura da quindicenni.) E chissà
cosa ne capisco oggi? L’unica cosa certa è che da allora, quando
arriva l’inverno, rileggo ritualmente la Lettera.
Sono passati trent’anni, e potrei dire che ogni volta sono ben
diverse le emozioni, le reazioni, le suggestioni. Ben diverse le
svolte e le aperture. Ma un verso, quello in cui si parla del «vecchio
orribile Kipling», mi pare mi colpisca sempre nello stesso modo: si
riapre una ferita e si rinnova un amore. So bene quali orribili cose abbia scritto e fatto e sostenuto il «vecchio orribile Kipling», ma altrettanto bene so quanto io l’abbia amato e lo ami, con quale incondizionata passione ne pratichi e ne consigli la lettura. Certo, l’amore è per il
Kipling di cui parlava Silvio D’Arzo in un
saggio scritto tra il 1946 e il 1950 e leggibile ora in Contea
inglese (Sellerio 1987), il Kipling «senza trombe», «senza
turbante e elmo bianco» delle Storie
proprio così, dei Libri
della Giungla, di Puck delle
colline (e anche di Kim).
E anch’io, come D’Arzo, mi faccio aiutare dal pensiero che «Gramsci,
la più alta vittima della giungla italiana di quei tempi, dal fondo
della sua prigione, consigliava i libri di Kipling a suo figlio. Io,
m’accontento».
Adesso c’è una ragione in più
(anzi, ce ne sono due) per leggere o rileggere «il vecchio orribile
Kipling». Sono infatti uscite recentemente due importanti nuove
edizioni, entrambe per la traduzione di Ottavio Fatica: Kim
presso Adelphi e I libri della
Giungla e altri racconti di animali nei Tascabili Einaudi.
Quest’ultimo è la versione economica del prezioso “Millennio”
uscito nel 1998 e, oltre ai due bellissimi Libri
della Giungla e alcune storie di cani (ma c’è anche Cam
e il porcospino e La storia
del Tabù), ripropone in una nuova felice traduzione le mirabili
narrazioni eziologiche delle Storie
proprio così, che Kipling scrisse per la prediletta Effie, la
figlia Josephine. Bisogna davvero leggerle ad alta voce, come peraltro
sosteneva lo stesso Kipling, e ci si troverà ad operare dentro la
moltiplicazione di un gesto d’amore. |